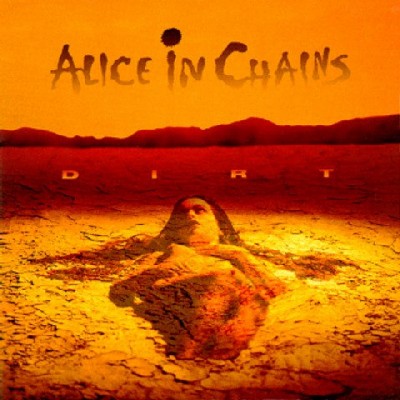I want to show you something, like joy inside my heart
Seems I been living in the temple of the dog
Where would I live if I were a man of golden words
Or would I live at all
Temple of the Dog è un progetto-tributo a Andrew Wood, compianto frontman dei Mother Love Bone. Arruolati i reduci Gossard e Ament, si aggiunge Mike McCready (questi tre saranno la piattaforma musicale dei nascenti Pearl Jam), batteria e voce affidati rispettivamente a Matt Cameron e a Chris Cornell provenienti dai Soundgarden. Proprio Cornell firmerà le 10 liriche dell’album e ne caratterizzerà fortemente l’atmosfera celebrativa.
Non siamo così lontani dagli inizi roboanti e ruvidi del grunge Sub Pop o dal sound “californiano” di Wood; piuttosto la ricercatezza e la cura del dettaglio fanno pensare ad un hard-blues pomposo e monumentale; nonostante il disco sia stato registrato nei week-end liberi delle rispettive band di provenienza.
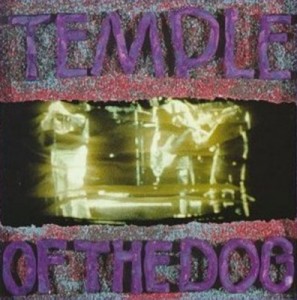 Quello che affascina di più in Temple of the Dog è la maturità nella stesura dei brani e nella composizione degli arrangiamenti (se si pensa che ogni singolo membro è poco più che ventenne) e, nel caso dei Soundgarden, l’energia endemica di Cornell pervade l’intero disco di un’energia animale e viscerale.
Quello che affascina di più in Temple of the Dog è la maturità nella stesura dei brani e nella composizione degli arrangiamenti (se si pensa che ogni singolo membro è poco più che ventenne) e, nel caso dei Soundgarden, l’energia endemica di Cornell pervade l’intero disco di un’energia animale e viscerale.
L’inizio è platonico ma molto toccante, Say Hello to Heaven non potrebbe suonare diversamente, mescolando le dinamiche della chitarra di Gossard (non così pulita come nei Mother Love Bone) con l’incisività della batteria di Cameron e soprattutto l’enfasi vocale di Cornell, vero mattatore di tutto l’album. La lunghezza dei brani è prolungata oltremodo, il gioco di voci e chitarre, di sovra-incisioni e cori assumono il carattere commemorativo che si addice ad un album di questo tipo. Reach Down porta all’ennesima potenza questo schema, con una interminabile parte di assolo quasi dinosaura, che conduce il brano sino a 11 minuti: leziosi sì, ma anche molto convincenti.
Hunger Strike vede la partecipazione come seconda voce di Eddie Vedder (futuro frontman dei Pearl Jam) e il brano suona molto come alla fine sarà Ten, loro esordio. E’ uno dei brani meglio riusciti e calorosamente accolti dai fans: non a caso il duetto vocale Cornell-Vedder convince per intensità e passione, tanto da essere ripetuto negli sporadici live, quando le rispettive band saranno definitivamente affermate.
Pushin Forward Back suona come un’estensione vera e propria dei Soundgarden, con la sei corde di Gossard che sembra richiamare in tutto e per tutto le dinamiche sixities tipiche di Kim Thayil. La pomposità tocca i vertici nelle atmosfere dilatate e lente di Call me a Dog, preghiera sofferta di un Cornell nostalgico ma anche assorto nella sua interpretazione «But when it’s my time to throw / The next stone I’ll call you beautiful , if I call at all».
La successiva Times of Trouble è il pianoforte che accompagna i nostri in un’esibizione volutamente toccante: nonostante tutta l’energia ed il commiato generato, entrambe, vagamente, risentono della retorica del tributo. Il blues di Wonder Jesus accarezza per un momento le atmosfere più torbide «Can I be saved, I spent all my money on a future grave / Wooden Jesus I’ll cut you in on twenty percent of my future sin», cercando nelle grandi icone la salvezza dal materialismo crescente dell’America reeganiana. Un valore aggiunto all’album che dopo più di mezzora di ascolto non risente di alcun calo o stanchezza compositiva.
Your Savior aggredisce l’ascoltatore tenendolo attivo in virate del tipo «Give me your brand, burn on my hand» invocando (e prevedendo) una caccia alle streghe verso la nuova scena musicale di Seattle; i ritmi rallentano con le ultime ballate: Four Walled World con concessioni psichedelico-zeppeliane, e la leggera marcia All Night Thing in cui addirittura si può apprezzare l’organo.
Nonostante Temple of the Dog sia stato suonato dal vivo solo a Seattle poco dopo l’uscita nell’aprile del 1991, non lo si può liquidare come semplice tributo da studio o le prove generali su major (il disco è pubblicato su A&M Records) di Soundgarden e Pearl Jam. Nonostante oggi Cornell non vada troppo fiero di questo disco, è innegabile la forza e una certa purezza di fondo, mostrando (con buona dose di preveggenza) lo scippo delle major verso quella generazione di musicisti indipendenti che aveva dato a Seattle ed alla provincia un paio di boccate d’aria fresca.