Prendendo ispirazione dal premio Nobel per la letteratura André Gide, che nel suo Retour de l’U.R.S.S. del 1936 poneva le prime perplessità sul modello stalinista dopo un breve soggiorno nella terra sovietica, così il sottoscritto prova a buttare giù qualche bislacca considerazione sull’indie italiano e la percezione di questo come genere musicale, alla luce dell’importante apertura mediatica avvenuta negli ultimi 18 mesi.
Se in Gide la perdita delle illusioni verso “l’uomo nuovo” del socialismo si poneva storicamente nel momento del massimo interesse verso l’U.R.S.S., nel mio compitino non mi pongo grandi obiettivi ed aspettative (nonostante i riflettori puntati sull’indie), tuttavia vorrei manifestare un certo disagio verso la musica di cui questo spazio di recensioni si è ampiamente occupato, sperando magari di ricevere delle risposte o delucidazioni da chi lo vive e lo ha vissuto in prima persona e da vicino.
Innanzitutto, doverosa è la definizione che vorrei dare di indie italiano: musica nata e cresciuta in sui palcoscenici italiani, cantata in madrelingua da band o singoli con una carriera discografica non superiore ai 10 anni, con discrete doti tecniche musicali (quindi nessun virtuosismo!) che fanno da tappeto a liriche che aleggiano tra il personale e la condivisione di esperienze comuni (con palesi riferimenti iconici) a cui i giovani -generalmente- sotto i 30 anni possano identificarsi. Se si vuole circoscrive l’anno zero ad un disco in particolare, la macchina del tempo a ritroso si ferma al maggio 2008, quando uscì Canzoni da Spiaggia Deturpata de Le Luci della Centrale Elettrica (anche se  avrebbe più crediti il demo del 2007 autoprodotto dallo stesso Vasco Brondi). Definito strettamente quello che in questo articolo considero indie italiano (si badi bene, questa definizione ha unicamente valore personale!), in Heart of Glass ne è stato seguito il percorso sin dal 2009, tra band esordienti ed artisti che nel corso dei successivi dieci anni sono passati a produzioni più importanti o a succursali delle major. Francamente è stato molto interessante osservare dal vivo ed ascoltare in cuffia l’evoluzione di alcuni di questi artisti, che oggi sono riconosciuti ed etichettati come indie italiano, ed ancora più soddisfacente constatare come radio e televisioni abbiano iniziato ad interessarsi all’argomento. Nonostante la solita cecità d’indagine dell’informazione generalista, è innegabile il bisogno di un cambio generazionale nella musica italiana, che francamente non poteva vivere di cantautori settantenni o di ex-icone degli anni ottanta e novanta o peggio ancora di meteore da talent. Il diverso modo di ascoltare la musica (dallo streaming, a youtube, passando ovviamente per il chiacchiericcio nei social) ha permesso all’ascoltatore 2.0, di approcciare a molteplici nomi e facce nuove: ecco che nell’autunno del 2016 The Giornalisti (ma già qualche mese prima Cosmo heavy-rotation o quasi su Radio Deejay) e poi Calcutta iniziavamo a gironzolare tra radio e tv commerciali. Il resto è storia recentissima e nota a tutti gli habituè, nel 2017 sono esondati gli argini dell’indie italiano ed una serie di uscite azzeccate ha permesso ad alcuni di questi artisti di farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Esaurito l’entusiasmo (che ha toccato i vertici nel concertone del primo maggio in diretta Rai), è corretto analizzare a mente fredda quanto successo e valutarne gli effetti nel breve periodo, dato che la macchina discografica indie è pronta per un nuovo giro di uscite. Ovviamente in questo lasso di tempo, accanto ai nomi oggi “altisonanti”, centinaia di altre band non hanno avuto altrettanta fortuna, ma sono andate ugualmente a rimpinguare quel misterioso contenitore che è la vera musica indipendente italiana. Non si deve confondere infatti l’indie italiano con l’independent italiano: non è solo una questione di copie vendute, spettatori ai concerti o di un influenza social, la questione è più delicata ed ampia (probabilmente solo idealista!), che vorrei trattare con i guanti bianchi.
avrebbe più crediti il demo del 2007 autoprodotto dallo stesso Vasco Brondi). Definito strettamente quello che in questo articolo considero indie italiano (si badi bene, questa definizione ha unicamente valore personale!), in Heart of Glass ne è stato seguito il percorso sin dal 2009, tra band esordienti ed artisti che nel corso dei successivi dieci anni sono passati a produzioni più importanti o a succursali delle major. Francamente è stato molto interessante osservare dal vivo ed ascoltare in cuffia l’evoluzione di alcuni di questi artisti, che oggi sono riconosciuti ed etichettati come indie italiano, ed ancora più soddisfacente constatare come radio e televisioni abbiano iniziato ad interessarsi all’argomento. Nonostante la solita cecità d’indagine dell’informazione generalista, è innegabile il bisogno di un cambio generazionale nella musica italiana, che francamente non poteva vivere di cantautori settantenni o di ex-icone degli anni ottanta e novanta o peggio ancora di meteore da talent. Il diverso modo di ascoltare la musica (dallo streaming, a youtube, passando ovviamente per il chiacchiericcio nei social) ha permesso all’ascoltatore 2.0, di approcciare a molteplici nomi e facce nuove: ecco che nell’autunno del 2016 The Giornalisti (ma già qualche mese prima Cosmo heavy-rotation o quasi su Radio Deejay) e poi Calcutta iniziavamo a gironzolare tra radio e tv commerciali. Il resto è storia recentissima e nota a tutti gli habituè, nel 2017 sono esondati gli argini dell’indie italiano ed una serie di uscite azzeccate ha permesso ad alcuni di questi artisti di farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Esaurito l’entusiasmo (che ha toccato i vertici nel concertone del primo maggio in diretta Rai), è corretto analizzare a mente fredda quanto successo e valutarne gli effetti nel breve periodo, dato che la macchina discografica indie è pronta per un nuovo giro di uscite. Ovviamente in questo lasso di tempo, accanto ai nomi oggi “altisonanti”, centinaia di altre band non hanno avuto altrettanta fortuna, ma sono andate ugualmente a rimpinguare quel misterioso contenitore che è la vera musica indipendente italiana. Non si deve confondere infatti l’indie italiano con l’independent italiano: non è solo una questione di copie vendute, spettatori ai concerti o di un influenza social, la questione è più delicata ed ampia (probabilmente solo idealista!), che vorrei trattare con i guanti bianchi.
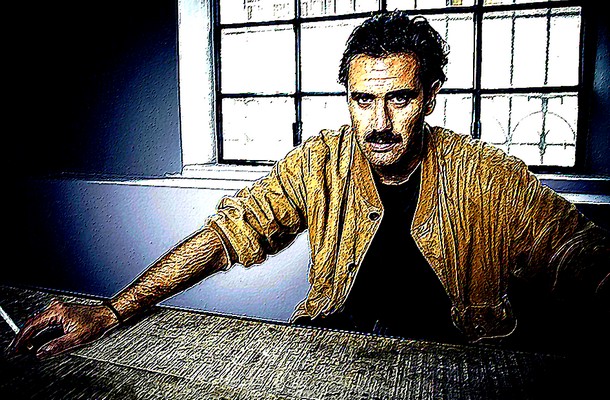 Su queste pagine hanno trovato spazio molte band che si sono autoprodotte, alcune senza label, altre invece con alle spalle giovani e promettenti realtà discografiche, che organizzano date, producono e distribuiscono dischi (talvolta pure cassette), spediscono convincenti comunicati stampa per ottenere visibilità nel mondo della critica musicale più o meno competente ed influente. Certamente una gran mole di lavoro, spesso sotterraneo ed invisibile, ma fondamentale per il mantenimento di un’etica indipendente, che di questi ultimi tempi ha visto molte tentazioni sul deserto della coerenza e del senso di appartenenza. E’ notizia di pochi giorni fa, dell’organizzazione di due “mega” concerti (uno allo stadio della natia Latina, l’altro all’Arena di Verona) di Calcutta: un sensibile triplo salto mortale, per un artista che viveva di concerti in piccoli -ma strategici- club o tutt’al più in palazzetti. Un traguardo di certo prestigioso, che sicuramente sposterà o stravolgerà gli equilibri nell’universo indie, ponendo l’etichetta Bomba Dischi (nata appena nel 2012) sopra una bella collinetta dove potrà godere di un bel panorama rispetto alle altre “concorrenti”, visto e considerato che in canna ha già rilasciato il nuovo disco di Pop X e ha trascorso un ottimo 2017 con la rivelazione Giorgio Poi (idolatrato da Rockit). Certo, il fenomeno Calcutta andrebbe studiato per bene, poiché riconosco un sottile scetticismo verso musica, contenuti ed immagine social che l’artista si porta appresso: Edoardo D’Erme ha una scrittura spontanea (con slogan e ritornelli pop perfetti), a tratti sboccata, ma dannatamente figlia di questi tempi e di questa generazione. L’unico cruccio che mi assale è dove inizi il Calcutta paroliere indipendente ed influencer e dove finisca il Calcutta che segue la corrente di un pubblico “indie” frivolamente esigente che pretende esattamente quel determinato contenuto. Se negli anni ottanta era “la vita spericolata” a raccontare le movenze e le turbolenze giovanili, le stesse tornavano sconfitte nelle nostalgiche “certe notti” nineties; oggi forse è “fare svastiche in centro a Bologna solo per litigare” a riassumere il senso di una generazione che non ha né cicatrici né memoria, e che ha conosciuto solo di striscio quegli anni novanta e la sua profonda inquietudine esistenziale.
Su queste pagine hanno trovato spazio molte band che si sono autoprodotte, alcune senza label, altre invece con alle spalle giovani e promettenti realtà discografiche, che organizzano date, producono e distribuiscono dischi (talvolta pure cassette), spediscono convincenti comunicati stampa per ottenere visibilità nel mondo della critica musicale più o meno competente ed influente. Certamente una gran mole di lavoro, spesso sotterraneo ed invisibile, ma fondamentale per il mantenimento di un’etica indipendente, che di questi ultimi tempi ha visto molte tentazioni sul deserto della coerenza e del senso di appartenenza. E’ notizia di pochi giorni fa, dell’organizzazione di due “mega” concerti (uno allo stadio della natia Latina, l’altro all’Arena di Verona) di Calcutta: un sensibile triplo salto mortale, per un artista che viveva di concerti in piccoli -ma strategici- club o tutt’al più in palazzetti. Un traguardo di certo prestigioso, che sicuramente sposterà o stravolgerà gli equilibri nell’universo indie, ponendo l’etichetta Bomba Dischi (nata appena nel 2012) sopra una bella collinetta dove potrà godere di un bel panorama rispetto alle altre “concorrenti”, visto e considerato che in canna ha già rilasciato il nuovo disco di Pop X e ha trascorso un ottimo 2017 con la rivelazione Giorgio Poi (idolatrato da Rockit). Certo, il fenomeno Calcutta andrebbe studiato per bene, poiché riconosco un sottile scetticismo verso musica, contenuti ed immagine social che l’artista si porta appresso: Edoardo D’Erme ha una scrittura spontanea (con slogan e ritornelli pop perfetti), a tratti sboccata, ma dannatamente figlia di questi tempi e di questa generazione. L’unico cruccio che mi assale è dove inizi il Calcutta paroliere indipendente ed influencer e dove finisca il Calcutta che segue la corrente di un pubblico “indie” frivolamente esigente che pretende esattamente quel determinato contenuto. Se negli anni ottanta era “la vita spericolata” a raccontare le movenze e le turbolenze giovanili, le stesse tornavano sconfitte nelle nostalgiche “certe notti” nineties; oggi forse è “fare svastiche in centro a Bologna solo per litigare” a riassumere il senso di una generazione che non ha né cicatrici né memoria, e che ha conosciuto solo di striscio quegli anni novanta e la sua profonda inquietudine esistenziale.
Roma è un megafono musicale molto importante in questi ultimi anni, lo testimonia il successo di Tommaso Paradiso, Niccolò Contessa (quest’ultimo romano acquisito) e di Francesco Motta; ma se i primi due possono già vantare una discreta discografia, per l’ex Criminal Jokers con il brillante esordio si sono accese quasi subito le luci della ribalta (Targa Tenco nel 2016). Merito anche della Woodworm Label (nata ad Arezzo nel 2011 ed ormai avviata ad essere la nuova La Tempesta) e a Riccardo Sinigallia che ha curato la produzione e  la scrittura di La Fine dei Vent’anni; premure ed attenzioni che forse non si addicono ad una produzione indipendente, ma a qualcosa di un po’ più ambizioso ed organizzato. Perché a pensarci bene il riferimento più importante per questi artisti dell’indie italiano non è né il rock, né il folk, né la sfocata wave, bensì quasi unicamente il pop (da Cosmo, ai Canova, passando per gli Ex-Otago, arrivando fino a Lo Stato Sociale), attingendo agli estremi del pubblico medio generalista, quello più esigente ed edulcorato, quello che ho definito “alternativamente” generalista. Un pubblico che ascolta l’indie in radio o nelle playlist di Spotify, lo ascolta come fosse un genere (oramai a questo punto lo è), ignorando o semplicemente non considerando le migliaia di sotto-strati di musica indipendente ed emergente sparsi per la penisola.
la scrittura di La Fine dei Vent’anni; premure ed attenzioni che forse non si addicono ad una produzione indipendente, ma a qualcosa di un po’ più ambizioso ed organizzato. Perché a pensarci bene il riferimento più importante per questi artisti dell’indie italiano non è né il rock, né il folk, né la sfocata wave, bensì quasi unicamente il pop (da Cosmo, ai Canova, passando per gli Ex-Otago, arrivando fino a Lo Stato Sociale), attingendo agli estremi del pubblico medio generalista, quello più esigente ed edulcorato, quello che ho definito “alternativamente” generalista. Un pubblico che ascolta l’indie in radio o nelle playlist di Spotify, lo ascolta come fosse un genere (oramai a questo punto lo è), ignorando o semplicemente non considerando le migliaia di sotto-strati di musica indipendente ed emergente sparsi per la penisola.
L’indie italiano è un prodotto che oggi si vende (e si vende anche bene), e giustamente anche queste piccole label seguono l’onda per remunerare (e probabilmente anche per rimanere a galla in un mercato estremamente competitivo), eppure lo fanno non tanto a scapito della qualità (come farebbero le major), ma bensì della varietà e pluralità della proposta. Mi spiego meglio. Il rooster di queste label si sta continuamente rimpolpando di nomi nuovi, che spesso si accavallano l’uno sull’altro (anche all’interno della stessa etichetta), portando ad un pubblico curioso -ma progressivamente saturo- una proposta musicale che canta delle “sfighe” generazionali, sforzandosi di essere originale più nella sostanza lirica e compositiva che nella forma musicale, rasentando le dinamiche pop con una puntualità a volte impressionante. La “bolla” dell’indie italiano sta crescendo, è crescerà, ma come ogni bolla è destinata ad esplodere, e potrebbero essere le stesse label indipendenti a farla scoppiare. Nonostante un’apparente uniformità di stile e messaggio artistico, si cela comunque una spigliata ricerca ed un evoluzione musicale individuale, che in alcuni casi si fa pigra o perlomeno poco coraggiosa da un album all’altro: i binari sono tracciati, chi si spinge verso gli estremi, chi meno, ma in sostanza molti artisti dell’indie italiano bazzicano tra questi rigidi confini, più per volontà (o opportunità?!) che per ragioni tecnico-stilistiche. E la critica musicale non sempre aiuta: molto spesso si adagia su posizioni troppo entusiastiche ed accondiscendenti, e non rivelando alcuna contraddizione, sale sul carrozzone delle lodi e continua la propria girandola di recensioni, senza approfondire le meccaniche della musica indie in relazione al proprio pubblico ed alla proprie origini.
Dulcis in fundo, la baggianata della gavetta che ogni tanto salta fuori dalle lingue più biforcute, per screditare il nuovo che avanza rapido e leggiadro. A mio parere avere più album (ed anni d’esperienza) alle spalle, permette di comporre e fare musica con un maggiore ventaglio di possibilità, forse una ricerca del dettaglio più fine, ma più in generale una amalgama sonora decisamente migliore. Non a caso i padri putativi dell’indie italiano, ossia Baustelle e Zen Circus, immersi nel pentolone indie di una qualsiasi playlist in streaming, riemergono e si fanno riconoscere immediatamente -e non tanto per la nomea che si portano dietro- piuttosto per una classe compositiva diversa, un sapore stantio ma invitante dato dall’esperienza pluridecennale (nonostante la Warner nel caso dei Baustelle). Perciò se ha senso parlare di gavetta (non di certo nel termine da camerata col quale spesso se ne sentono di cotte e di crude), lo si deve fare con molta attenzione e con orecchi attenti ed esperti: non sono gli anni di esperienza che contano, né i dischi suonati, né tantomeno i metodi di produzione, ma la passione, la dedizione, la visione con cui si realizza un album o un qualsiasi lavoro adiacente. Tuttavia anche grazie alla -col senno di poi- sciagurata scelta di Manuel Agnelli di presenziare ai talent-show, la televisione generalista ha spalancato le braccia al nuovo ruolo del musicista che gioca a fare il conduttore, non tanto per perorare la causa indie, piuttosto per pre-pensionare la vecchia e decadente guardia dei vari Jovanotti, Ligabue e Vasco Rossi (con quel pizzico di rivalsa quando questi surfavano sulla cresta dell’onda e, vedasi gli Afterhours, giravano al massimo nei palazzetti): presto sia Brunori che Agnelli sbarcheranno in Rai, e francamente non ne concepisco il motivo! Levante invece ha fatto un percorso simile più per opportunità che per esigenza di visibilità, pagando lo scotto di una pressoché nulla esperienza televisiva, e palesando una mancanza di personalità che nel piccolo schermo non perdona. Diventa difficile rivederla con addosso i panni dell’eroina indie alternativa, speriamo solo che non perseveri sulla strada dei talent-show.
 In queste pagine è stato dato spazio anche all’indie italiano inteso come genere, cercando sempre di scrivere della critica funzionale alla musica, senza abbandonarsi ad istinti e gusti personali. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, con alle porte i nuovi lavori di Motta, Cosmo, Calcutta, (forse, ma chissà in quale forma) I Cani e la partecipazione de Lo Stato Sociale al festival di Sanremo, non ha più molto senso dedicare altre righe all’indie italiano, sacrificando ascolti e tempo prezioso per la vera musica indipendente italiana. Una scelta né sofferta, né dolorosa, semplicemente una presa di posizione verso della musica che diec’anni fa sembrava una bella utopia e che oggi è una realtà non così poi piacevole come l’avevo immaginata. Calcutta che riempie l’Arena di Verona non è independent, è al massimo il giusto (ed anche sacrosanto) ricambio generazionale, che speriamo annichilisca gli ultimi e fastidiosi residui della deriva talent nel quale è stata sottomessa l’Italia musicale degli ultimi diec’anni. A patto che l’indie italiano (come sopra definito) non finisca per assoggettarsi alle regole di un mercato discografico ove la vacuità di contenuti sia la mesta ed obbligata regola da inseguire a favore di un consenso nazional-popolare. Che i proclami di Calcutta e The Giornalisti (Mainstream e Completamente Sold Out) non siano in realtà dei massonici complotti in codice per dare una dipintura di fresco alla discografia italiana, che la carcassa putrefatta dell’indie non marcisca su una qualsiasi spiaggia deturpata.
In queste pagine è stato dato spazio anche all’indie italiano inteso come genere, cercando sempre di scrivere della critica funzionale alla musica, senza abbandonarsi ad istinti e gusti personali. Tuttavia, allo stato attuale delle cose, con alle porte i nuovi lavori di Motta, Cosmo, Calcutta, (forse, ma chissà in quale forma) I Cani e la partecipazione de Lo Stato Sociale al festival di Sanremo, non ha più molto senso dedicare altre righe all’indie italiano, sacrificando ascolti e tempo prezioso per la vera musica indipendente italiana. Una scelta né sofferta, né dolorosa, semplicemente una presa di posizione verso della musica che diec’anni fa sembrava una bella utopia e che oggi è una realtà non così poi piacevole come l’avevo immaginata. Calcutta che riempie l’Arena di Verona non è independent, è al massimo il giusto (ed anche sacrosanto) ricambio generazionale, che speriamo annichilisca gli ultimi e fastidiosi residui della deriva talent nel quale è stata sottomessa l’Italia musicale degli ultimi diec’anni. A patto che l’indie italiano (come sopra definito) non finisca per assoggettarsi alle regole di un mercato discografico ove la vacuità di contenuti sia la mesta ed obbligata regola da inseguire a favore di un consenso nazional-popolare. Che i proclami di Calcutta e The Giornalisti (Mainstream e Completamente Sold Out) non siano in realtà dei massonici complotti in codice per dare una dipintura di fresco alla discografia italiana, che la carcassa putrefatta dell’indie non marcisca su una qualsiasi spiaggia deturpata.
Non tutto quello emerge dalla forte concorrenza musicale deve essere per forza la migliore, questo indie ne è la prova; per questa ragione -ed in direzione ostinata e contraria- Heart of Glass continuerà a battersi a mani nude per la musica indipendente, per quel che può servire, con la determinazione che ancora riesce a tirare fuori. Essere indipendenti a volte non è solo una scelta, talvolta è una maledetta vocazione …
La Firma: Poisonheart






